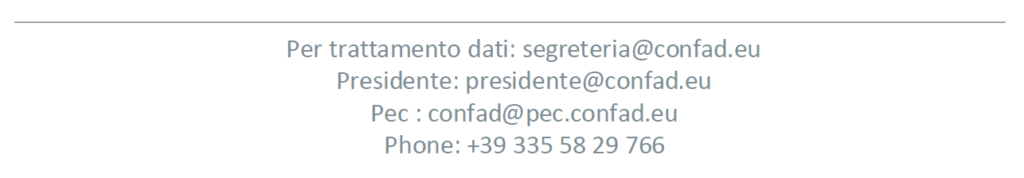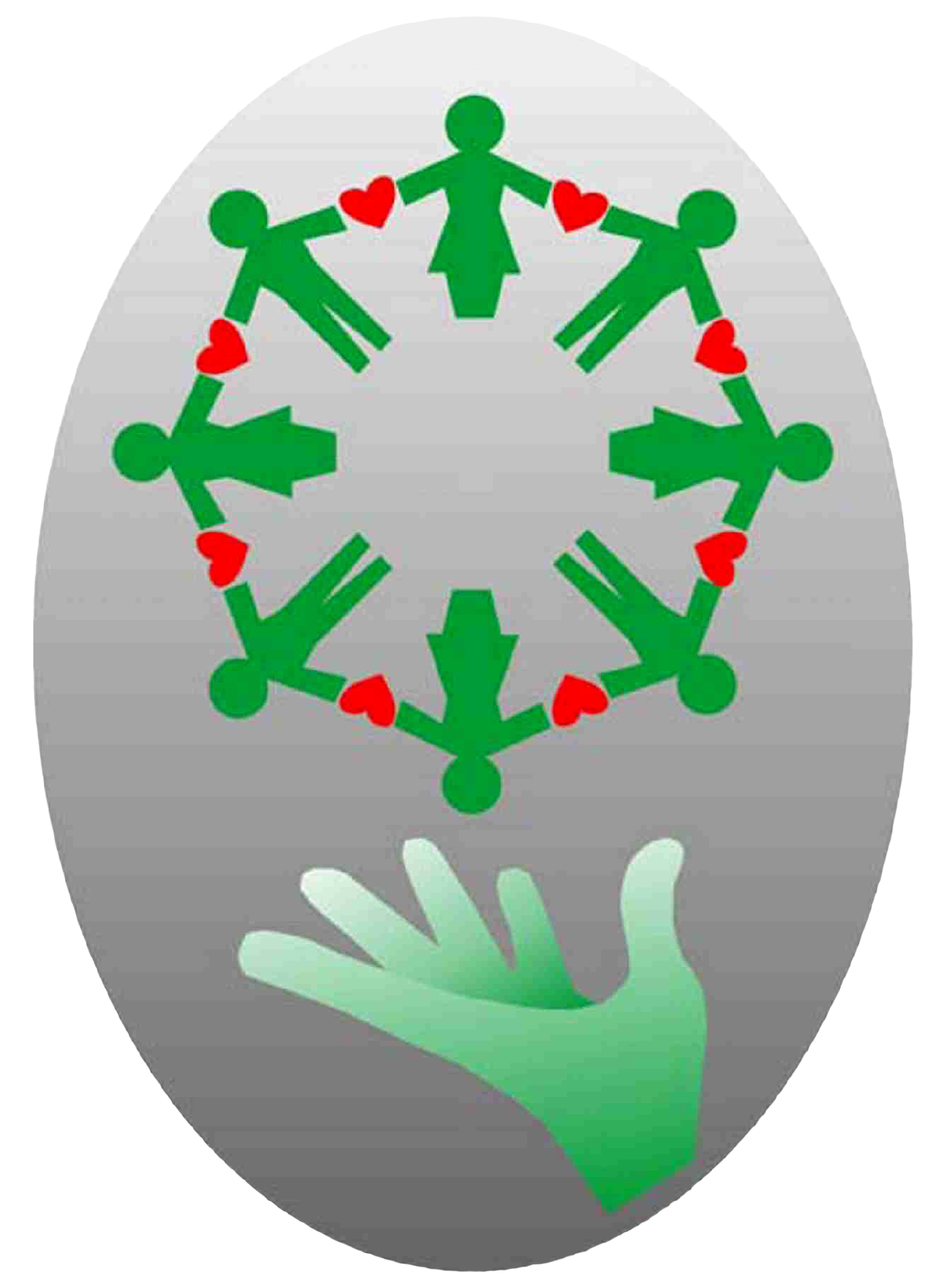3 Maggio 2025 – Le “stragi familiari” delle famiglie con disabilità, invisibili e ignorate: in che società viviamo?

Continua ad accadere, puntualmente. Ormai sappiamo che ci ritroveremo di nuovo, prima o poi, il titolo in prima pagina o la notizia rimbalzata sui diversi social, dell’ennesimo caso di cronaca nera etichettato come “strage familiare”. Il racconto è già abbastanza noto, sappiamo anche questo. La storia si ripete. Sembra di leggere sempre lo stesso canovaccio di vita, in cui di volta in volta cambiano solo le varianti familiari: all’improvviso e senza segnali d’allarme la persona che si è presa cura, spesso per una vita intera, di un suo caro con disabilità, un giorno decide che non può più andare avanti così. E allora compie l’estremo gesto. Uccide proprio la persona cui ha dedicato ogni giorno della sua stessa esistenza e poi si toglie la vita. Omicidio-suicidio, strage familiare. Il tutto precipita e si condensa dentro questi termini.
Gesto di pura follia, di totale disperazione o di incondizionato amore, secondo la bontà di chi legge. Non sta a noi giudicare questo. Ciò che noi, invece, abbiamo il dovere di giudicare è la società in cui viviamo che non si accorge di cosa stia accadendo. La domanda che continua a interrogarci è perché la società non sa (più) riconoscere la fragilità. Anzi, la evita.
La evita perché di queste situazioni se ne devono fare carico lo Stato, gli Enti preposti, magari le associazioni, o comunque sempre qualcun altro. Ma la evita anche compiacendo e ammirando la forza d’animo, o chissà cosa, di quelle persone dipinte sempre come “angeli” che se ne prendono con amore tutto il dramma, sempre però a una certa distanza, senza mai arrivare a toccare da vicino quella normalità che nessuno sente appartenergli. “Che supereroi!” si sente spesso dire dei genitori che si prendono cura del figlio che continuano a definire “speciale”. Supereroi sono anche il fratello o la sorella o anche il coniuge o il nipote. Per non parlare, poi, delle “Mamme-coraggio” che sono senza dubbio la categoria per eccellenza dell’inarrivabile dedizione di vita totale. Ed è vero. Effettivamente è così. Ma la vita vera, poi, di queste persone chi la vede?
A chi interessa la vita dei caregiver familiari conviventi delle persone con disabilità?
Allo Stato? Ci battiamo da anni per una legge nazionale, che in Italia ancora manca, sul riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare (soprattutto convivente) che ne preveda i diritti fondamentali della persona e le giuste tutele: aspettiamo risposte che lo Stato italiano ancora oggi, indegnamente, non ci dà.
Agli enti locali preposti? Loro, sempre in perenne mancanza di fondi, o comunque con una visione della gestione dei fondi non attenta a questo tipo di problematica, e con personale non formato a supportare il bisogno vero delle famiglie con disabilità grave, di certo non sono un riferimento sicuro. Infatti, ogni volta continuiamo a chiederci perché i servizi sociali si mobilitano solo quando si palesano le emergenze e invece non riescono a mettersi al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per accompagnare, ascoltarle, cercare soluzioni insieme, senza che queste si sentano smarrite e tradite dalla vita.
Alle associazioni? Tante fanno tanto. Ma non possono fare l’impossibile. E alla società?!?
Dov’è la società prima e dopo queste “stragi familiari”, che sarebbe più corretto definire “stragi dei caregiver familiari conviventi”? Non esistono dati ufficiali che registrino ufficialmente questi episodi. Sembra che avvengano dai 3 ai 5 casi all’anno, ma noi crediamo sia una stima a ribasso poiché molti di questi casi rimangono sommersi. Significa più o meno un caso ogni due mesi… Davvero una strage ignorata che continuerà senza fine se non cambia al più presto qualcosa.
L’ultima “strage familiare” rimbalzata alla cronaca è di qualche giorno fa e riguarda la morte di Gian Carlo Salsi, marito e padre 83enne che prima di impiccarsi, nel modenese, uccide la moglie, alla quale già da un paio d’anni era stata diagnosticata una forma di demenza, e il figlio 48enne con disabilità. Pare avesse ricevuto di recente anch’egli una diagnosi di malattia.
Che cosa scatta nella mente di un uomo logorato da un tempo così lungo di assistenza continuativa, senza pause, isolato con la sua famiglia, forse impoverito dal costo della disabilità e senza la visione di un futuro di rassicurante “dopo di noi”, non lo sappiamo.
Angoscia, rabbia, disperazione, depressione, senso di impotenza… Chi può dirlo? Sicuramente, però, la vita di una persona che ogni giorno porta avanti questo vissuto drammatico è attraversata da momenti in cui la condizione di burnout emotivo e fisico arriva a livelli di estrema gravità. Questo sì, possiamo dirlo.
Eppure, sui giornali si legge che non c’erano segnali di allarme, che lui era tranquillo come al solito, che i servizi sociali avevano in carico la famiglia.
Ma come è possibile che non ci siano stati segnali di allarme in una storia di vita del genere, anche ad una lettura superficiale, attraverso questi pochi ma fondamentali elementi emersi? Come è possibile che non ci siano stati segnali di allarme in una famiglia che vive uno stato di sofferenza tale, con un vissuto di vita così altamente logorante e disperante? Prima di una tragedia ci sono sempre segnali per chi li sa cogliere.
Ma la società non sa leggerli. “Era normale come sempre” è la risposta che si ripete, anche questa volta, dei vicini di casa. Come se fosse “normale” vivere così. Ma d’altra parte è anche vero che quella che vivevano era la loro normalità, la loro vita di tutti i giorni.
Di fronte alla notizia, in questi casi solitamente si pensa a una famiglia abbandonata dai servizi sociali o non pienamente supportata da chi avrebbe dovuto e l’analisi sociologica si ferma qui. Ma chi, appunto, avrebbe dovuto?
Bisogna andare oltre, è necessario che lo sguardo si spinga oltre. Lo sguardo di tutti. Per provare ad avere una visione più ampia e più approfondita proprio di quella loro normalità, del quotidiano che vivono queste famiglie con disabilità gravissima.
La domanda, allora, sorge spontanea. O almeno così dovrebbe.
Il contesto comunitario, il quartiere in cui vivevano dov’è? Non conta nulla? Cosa vuol dire vivere in una comunità?
“Far parte di una comunità significa far parte di una rete di relazioni autentiche, aperte all’ascolto e alla comprensione, cercando di riconoscere in tutte le persone una risorsa preziosa… Altrimenti si parla di scarto, di individualismo, di disinteresse per l’altro, soprattutto se diverso” (Papa Francesco).
Il punto in fondo è sempre questo, che la disabilità fa ancora rima con diversità.
Proviamo, allora, a immaginare: se quella famiglia fosse stata vista dai vicini, se ci fossero stati atti di accoglienza e di solidarietà concreta attraverso semplici gesti di vicinanza di quartiere (ti vado a fare la spesa? Hai bisogno di medicine? Venite a pranzo da noi? Ti do una mano in casa? Hai bisogno di riposare?), forse la fatica del vivere quotidiano sarebbe stata un po’ più leggera. Forse quei genitori si sarebbero sentiti meno soli. Forse…
Ogni caregiver familiare convivente sa bene quanto questi gesti possono essere un aiuto concreto, di sollievo fisico e morale nella vita di tutti i giorni.
Certo, con il passare del tempo, il “dopo di noi” rimane un annoso problema e il bisogno del riconoscimento delle tutele della persona urge sempre di più ma questi atti estremi forse potrebbero essere prevenuti se ci fosse uno sguardo più attento da parte di tutti. Ognuno, in una società civile, dovrebbe sentirsi chiamato alla responsabilità dell’altro più prossimo, a maggior ragione se in una condizione di bisogno. Cogliere i segnali della solitudine e della disperazione dei propri vicini di casa che vivono una situazione così pesante da tutti i punti di vista dovrebbe essere, questa, la normalità.
Occorre, insomma, uno sguardo più vero, che sappia interrogarsi senza subito delegare, meno giudicante ed escludente, della società tutta.
Occorre una cultura del NOI, senza distinzione e linee di difesa, in cui ognuno sappia avvicinarsi e fermarsi lì, davanti all’altro più fragile.
Occorre una società che voglia cogliere e sostenere la vulnerabilità delle vite altrui.
Lo ricordiamo sempre. I caregiver familiari conviventi assistono ogni giorno senza tregua il proprio caro con disabilità e i numeri delle persone con disabilità sono purtroppo in crescente aumento. Il 71% sono donne.
I caregiver familiari conviventi hanno estremo bisogno di sollievo, di pause per poter riposare, per potersi dedicare alla cura di sé e degli altri componenti della famiglia (pensiamo ad es. ai siblings). Non hanno vita sociale. Spesso hanno dovuto rinunciare al lavoro.
Il primo marzo di ogni anno si celebra la giornata mondiale del lutto dedicata alle persone con disabilità uccise dai loro caregiver familiari, il cosiddetto figlicidio. Non abbiamo bisogno di queste date.
Abbiamo bisogno di essere visti. E per questo è necessaria una narrazione diversa della normalità della disabilità, ovvero della vita delle famiglie con disabilità.
Perché i media si occupano di disabilità solo quando accadono episodi di cronaca nera o quando si organizzano eventi cosiddetti inclusivi o quando si tratta di raccontare casi di abilismo?
Perché i media faticano a raccontare la disabilità per quella che è e cioè, semplicemente come parte della vita, con alti e bassi, luci e ombre, certo, ma anche, soprattutto con tanta voglia di vivere e di esserci da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie?
Perché non si riescono a raccontare le storie di ordinaria normalità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari conviventi, fatte ogni giorno di forza e caparbietà per portare a termine compiti che per gli altri sono semplici e scontati?
Quei gesti di ordinaria normalità che per 50 anni anche Gian Carlo Salsi ha compiuto tutti i giorni da quando era nato suo figlio con autismo e che ha continuato a compiere anche dopo che alla moglie era stata diagnosticata una forma di demenza, prima affiancando la moglie, poi prendendo completamente su di sé la cura del figlio e infine anche quella della moglie. Evidentemente, ha ceduto quando lui stesso ha scoperto di essere vulnerabile e di non poter più garantire ai suoi cari la vita che avevano condotto fino ad allora, probabilmente fatta di affetto ed attenzioni.
Perché i media non riescono a raccontare queste storie di umana vulnerabilità ma allo stesso tempo di forza e dignità?
Forse perché si preferisce non pensare al fatto che siamo tutti potenzialmente vulnerabili. L’essere umano può compiere imprese incredibili e allo stesso tempo ritrovarsi improvvisamente fragile. Fa parte della vita ma quest’ultimo aspetto si preferisce nasconderlo e pensare che tocchi sempre solo agli altri.
Perché i media continuano a evidenziare solo una parte della disabilità invece di raccontare le tantissime storie di vita di persone e famiglie con disabilità belle, ricche e piene di valori per la società?
Se… la società in cui viviamo fosse più consapevole del fatto che la fragilità, la malattia, la disabilità fanno parte della nostra stessa umanità, e che queste sono condizioni non da respingere e allontanare, per indifferenza o autodifesa, ma anzi possono essere (e di fatto sono) arricchenti per tutti, forse si riuscirebbe a costruire una socialità più attenta ai bisogni degli altri e, magari, queste “tragedie” potrebbero essere, almeno in parte, evitate.
Team comunicazione – Confad Aps